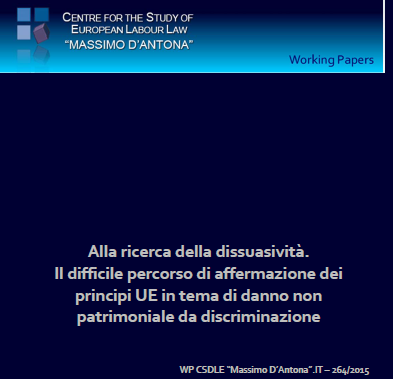Alla ricerca della dissuasività. Il difficile percorso di affermazione dei principi UE in tema di danno non patrimoniale da discriminazione. Avv. Lisa Amoriello
1. Le indicazioni a livello UE e il diritto positivo interno. I riflessi sull’onere della prova e sui criteri di liquidazione.
E’ noto che le varie direttive UE di diritto antidiscriminatorio impongano agli Stati membri di predisporre una tutela avverso le discriminazioni che sia connotata da requisiti di effettività, dissuasività e proporzionalità. E’ altrettanto noto che le direttive si limitano ad indicare gli obiettivi cui gli atti di implementazione debbano essere intesi, lasciando invece ai singoli Stati, ciascuno portatore di proprie e peculiari tradizioni giuridiche, ampia libertà sui mezzi e le forme attraverso le quali perseguire il risultato.
Non v’è dubbio, per quanto si dirà, che i requisiti di dissuasività, proporzionalità ed effettività non riguardino soltanto la tutela complessivamente intesa, ma debbano coesistere, nello specifico, in ciascuno degli strumenti che compongono l’apparato rimediale, e dunque non solo quelli a contenuto inibitorio e ripristinatorio, ma anche quelli, laddove previsti, a carattere risarcitorio. Il che, sul piano interno certamente è foriero di criticità, attesa la tradizionale refrattarietà dell’ordinamento civilistico a dare accesso a nozioni di risarcimento del danno che non siano meramente compensative(1)del pregiudizio subito (e,sul piano della prova, concretamente dimostrato (2)) dall’attore.
Su tutte, v. Cass. SS.UU. 24.3.2006, n. 6572, in tema di lesione alla dignità professionale cagionata da un demansionamento, ma con formulazioni di principio aventi portata ben più generale: “In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l’attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come sommacastigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostroordin amento”(3).
Che il risarcimento del danno, nell’ottica del legislatore eurounitario assolva, fra le altre, anche una funzione dissuasivo-punitiva, lo si può evincere dalle indicazioni delle direttive 2000/43 in tema di razza ed origine etnica e 2000/78 sui fattori religione, età, handicap, orientamento sessuale, convinzioni personali, che, rispettivamente agli art. 15 e 17 espressamente inseriscono il risarcimento del danno fra le sanzioni (4). Nello stesso senso può leggersi l’art. 18 della direttiva 2006/54 che, in materia di genere, richiede l’introduzione di misure necessarie per garantire un indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, tali cioè da essere dissuasivi e proporzionati al danno subìto, vietando al contempo la definizione a priori di massimali, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il datore di lavoro riesca a dimostrare che l’unico danno derivante al lavoratore dalla condotta discriminatoria sia stato rappresentato dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda (5).
Dal quadro sin qui sommariamente tratteggiato, letto alla luce del principio del primato del diritto comunitario, si può derivare che le norme di diritto interno poste in applicazione del diritto antidiscriminatorio di matrice UE che impedissero il realizzarsi di una tutela risarcitoria, oltre che effettiva e proporzionata, anche dissuasiva, dovrebbero considerarsi non correttamente trasposte – poiché la violazione riguarderebbe l’obiettivo stesso perseguito dalla direttiva (6) – e analogamente dovrebbe ritenersi per gli orientamenti giurisprudenziali intesi a negare cittadinanza, nella specifica materia, alla peculiare nozione di danno in discorso, con riferimento al dovere di interpretazione conforme che si impone al giudice nazionale (7).
Anche la Corte di Giustizia UE non ha mancato di pronunciarsi sul punto, per esempio nella sentenza 2.4.2013, causa C-81/12, Asociaţia Accept c. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, in tema di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, precisando in relazione ai principi della direttiva 2000/78 che, per tutte le misure che il diritto nazionale deve contemplare ex art. 17 (e dunque ciò vale anche per il rimedio risarcitorio) “una sanzione meramente simbolica non può essere considerata compatibile con un’attuazione corretta ed efficace della direttiva”.
Si pone allora il problema di verificare se e con quale grado di adesione le normative interne di diritto antidiscriminatorio abbiano recepito le indicazioni europee sulle caratteristiche che deve avere il danno, e quale sia l’atteggiamento della giurisprudenza rispetto a tali indicazioni.
Occorre innanzitutto ricordare che dal punto di vista interno la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da una condotta discriminatoria trova espresso fondamento ex lege; in ogni caso, attenendo la discriminazione alla lesione di un bene immateriale riferibile a diritti fondamentali della persona tutelati a livello primario e superprimario – segnatamente quello alla dignità che intitola anche il Capo I della Carta di Nizza, poi recepita dal Trattato di Lisbona – si tratta di fattispecie riconducibile sotto l’ombrello protettivo della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (artt. 2, 3, 4, 32 Cost.)(8),secondo l’impostazione inaugurata da Cass. 8827/2003 ed 8828/2003,poi seguita da Cass. 7181, 7182 e 7183/2003 e validata da Corte Cost. 233/2003, nonché, più recentemente da Cass. civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972 (in Nuova giurisprudenza civile, 2009, I, 102, con nota di E. Navarretta, G. Ponzanelli).
Si vedano, per la risarcibilità ex lege, il d. lgs. 286/1998, nella parte relativa all’azione civile contro le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 44, comma 7), il d. lgs. n. 215/2003 di attuazione della direttiva 2000/43 sulla parità di trattamento in materia di razza ed origine etnica (art. 4, comma 4) il d. lgs. 216/2003 di implementazione della direttiva 2000/78 relativa ai fattori religione, età, handicap, convinzioni personali, orientamento sessuale (art. 4, comma 4); il d. lgs. 145/2005 posto in attuazione della dir. 2002/73 in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, che ha inserito la risarcibilità del danno non patrimoniale ai commi 9 e 10 dell’art. 4 l. 125/1991 (v. art. 2, comma 1, lett. d ed e) e all’art. 15, comma 1, l. 903/1977 (v. art. 3, comma 2) e, successivamente, il d. lgs. 198/2006, recante il c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” (artt. 37, comma 3, e 38, comma 1); la l. 67/2006 nella parte relativa all’azione civile contro le discriminazioni per ragioni di disabilità (art. 3, comma 3). Il riferimento più recente è contenuto nel d. lgs. 150/2011, che, nel quadro della semplificazione dei riti civili ha assoggettato al rito sommario di cognizione le controversie in materia di discriminazione di cui all’articolo 44 d. lgs. 286/98, quelle di cui all’art. 4 d. lgs. 215/03 e all’art. 4 d. lgs. 216/03, quelle di cui all’art. 3 l. 67/2006, e quelle di cui all’articolo 55-quinquies d. lgs. 198/2006 e che, all’art. 28, e ribadito la facoltà, per il giudice, di condannare il convenuto, con l’ordinanza che definisce il giudizio, al risarcimento del danno anche non patrimoniale. All’interno delle disposizioni citate, il possibile fondamento di una connotazione anche dissuasiva del rimedio risarcitorio può rinvenirsi nella formulazione degli artt. 4, comma 5, d. lgs. 215/03 e 4, comma 6, d. lgs. 216/03, oggi abrogati (9), ma ripresi nel contenuto che qui interessa dall’art. 28, comma 6, d. lgs. 150/2011, che prevede che il giudice tenga di conto, nella liquidazione del danno, del fatto che l’illecito possa aver
costituito una ritorsione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento. Come è stato efficacemente rilevato(10), poiché è difficilmente sostenibile che il danno provocato da una discriminazione per ritorsione sia di per sé maggiore di quello cagionato da una condotta identica, ma perpetrata per ragioni non ritorsive, evidentemente il maggiore apprezzamento richiesto al giudice deriva dal riconoscimento di una funzione del danno eminentemente sanzionatoria e non semplicemente compensativa.
Ma, a ben vedere, la prospettiva dissuasiva risulta implicita negli stessi tratti distintivi assunti nel nostro ordinamento dall’azione collettiva degli organismi portatori dell’interesse leso dalla discriminazione (che, nell’ambito della tutela del fattore-genere è demandata alla Consigliera di parità e riveste addirittura carattere “pubblico”). Il che può assumere particolare significato laddove si consideri che l’introduzione di un’azione giudiziaria a carattere collettivo non è affatto istituto necessitato dalle direttive(11), sul punto dovendosi forse, al contrario, ritenere che il legislatore italiano abbia provveduto autonomamente a colmare vistose lacune della disciplina comunitaria.
Come noto, l’ipotesi nella quale l’azione collettiva è in grado di dispiegare più pienamente la propria incisività è quella della discriminazione indiretta, in particolare nei confronti di un gruppo nel quale non siano immediatamente individuabili le vittime: si tratta del caso di discriminazione più “sistemico” e forse dell’unico davvero
potenzialmente lesivo di tutti i membri della comunità presa a riferimento(12). Addirittura, per i fattori diversi dal genere, quello in esame parrebbe l’unico caso possibile di operatività dell’azione collettiva, stante la (criticabile) formulazione letterale di cui all’art. 5, ultimo comma, del d. lgs. 215/03 e del d. lgs. 216/03, che sembra escludere le discriminazioni di gruppi di soggetti nominati(13).
Non è dubitabile che, con riferimento a qualsiasi fattore di discriminazione esaminato dalle disposizioni, l’organismo che propone l’azione collettiva possa richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale (per una casistica si rimanda a quanto sub § 2).
L’ipotesi così congegnata, evidentemente, si pone in contrasto con un’idea del risarcimento meramente riparatoria; è peraltro evidente che, nominati o meno che siano i soggetti del gruppo, il danno non patrimoniale – come del resto l’azione collettiva in sé – rivesta qui un ruolo che trascende la sommatoria dell’interesse dei singoli, e sia strumentale alla stessa affermazione del principio di uguaglianza sostanziale. La ricostruzione ha certamente trovato conferma in giurisprudenza, in particolare da quando Cass., sez. VI pen., 16 aprile 2009, n. 16031 (in Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 2009, 305) ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile nel processo penale ex art. 74 c.p.p. della Consigliera regionale di parità jure proprio come soggetto danneggiato dal reato, in un caso di maltrattamenti perpetrati da un preposto del datore ai danni di una collettività (individuata) di lavoratrici, con ciò riconoscendo che il danno risarcibile attraverso l’azione collettiva possa identificarsi con il pregiudizio agli scopi istituzionali dell’ente e all’azione di contrasto delle discriminazioni che esso si propone. Il che, per venire a ciò che qui interessa, conclama l’assoluta indeterminatezza dei risvolti risarcitori della vicenda discriminatoria, elemento certamente non irrilevante sotto il profilo della dissuasività(14).
Le considerazioni che precedono mi pare peraltro conducano verso un ulteriore arricchimento della funzione del danno rispetto a quella dissuasiva o afflittiva nei confronti del singolo autore dell’illecito, e cioè verso un’idea addirittura general-preventiva e deterrente rivolta alla collettività dei consociati, specialmente nei casi nei quali alla misura risarcitoria si accompagni quella – parimenti prevista da numerose disposizioni di diritto antidiscriminatorio(15), ma non ancora sufficientemente valorizzata(16) – della pubblicazione della decisione a spese del convenuto soccombente su un quotidiano a tiratura nazionale.
Sul piano delle conseguenze del nostro discorso sulla dissuasività, non è poi chi non veda come il superamento della tradizionale chiusura al danno sanzionatorio consenta di rivedere le impostazioni sin qui prevalenti sulla necessità di una prova in concreto del danno non patrimoniale come conseguenza dell’illecito, in aggiunta alla necessaria dimostrazione, a monte, della sussistenza di una discriminazione vietata.
Il tema meriterebbe ben altri approfondimenti, ma in sostanza, laddove il lavoratore ricorrente abbia dimostrato, anche attraverso i noti meccanismi di agevolazione, di aver subito un trattamento differenziale deteriore e la sussistenza di un collegamento fra quel trattamento e l’appartenenza al fattore vietato (in assenza di prova – stavolta a carico del datore – della presenza di una causa di giustificazione o di un’ipotesi derogatoria ai sensi della disciplina di riferimento o, a seconda delle ricostruzioni, di una ragione alternativa lecita), il risarcimento del danno non patrimoniale dovrebbe essere liquidato senza necessità di prova di fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli che sono serviti a circostanziare la discriminazione, che è per definizione atto lesivo della dignità umana – umiliante a prescindere, verrebbe da dire – e risarcibile per espressa volontà di legge. Del resto, di quali fatti ulteriori e diversi, esterni alla discriminazione, chi si asserisce vittima sarebbe tenuto a fornire dimostrazione, è rimasta tuttora l’incognita, avendo mostrato tutta la loro artificiosità, nella materia in discorso, quelle ricostruzioni giurisprudenziali sul danno non patrimoniale tendenti ad imporre a chi propone la domanda di rappresentare lo specifico tipo di pregiudizio immateriale subito in termini di alterazione delle relazioni personali, di stravolgimento delle abitudini di vita, o di malessere psichico o fisico, e la sua qualificazione (esistenziale, morale, etc…). Quest’ultima essendo, a mio avviso, solo apparentemente superata dall’approccio “unitario” di Cass. civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972, cit., comunque pregevole sotto il diverso profilo della valorizzazione della possibilità di una prova presuntiva del danno non patrimoniale.
La liquidazione non può essere che equitativa(17), ma proprio l’osservanza del principio di dissuasività dovrebbe condurre a spostare l’attenzione dalle sole conseguenze prodotte nella sfera giuridica della vittima, alla persona del responsabile(18) e (per il combinato disposto con il principio di proporzionalità) alle caratteristiche della condotta, e al suo livello di antigiuridicità, in relazione alla quale potranno influire elementi come la rilevanza penale, la durata o la reiterazione, l’eventuale plurioffensività dei comportamenti, il grado di responsabilità/colpevolezza o di adesione psicologica dell’autore che, totalmente irrilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie, sarebbe qui destinato a riacquisire importanza primaria. Non da ultimo, l’eventuale arricchimento, anche in termini di contenimento di costi, che questi abbia tratto dall’illecito(19)
2. Panoramica giurisprudenziale.
Le pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite sui temi oggetto del presente scritto, anche se con alcune recenti e significative adesioni ai principi comunitari di cui si dirà, non sono ancora pienamente soddisfacenti in ordine all’accoglimento della prospettiva dissuasivosanzionatoria, e men che meno di quella general-preventiva.
Si registrano casi di liquidazione del danno non patrimoniale irrisoria, e dunque di scarsa o nulla efficacia deterrente, anche a fronte di casi gravi discriminazioni a carattere collettivo, per i quali valga, su tutte, Trib. Varese 2.7.200820; casi di discutibile interpretazione della funzione del rimedio risarcitorio, e delle finalità delle azioni collettive, come quello della nota ordinanza ex art. 28 d. lgs. 150/2011, pur di estremo rilievo sotto diversi altri profili, di Trib. Roma, III sez. lavoro, 21.6.2012 sul caso Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A./Fiom CGIL Nazionale, ove a fronte dell’accertata discriminazione verso l’intera collettività dei lavoratori ex Fiat iscritti alla Fiom21, il danno non patrimoniale è stato liquidato soltanto ai 19 membri del gruppo rappresentati in giudizio tramite espressa delega al sindacato ricorrente, sulla base dell’assunto che “la volontà di agire da costoro manifestata costituisce prova sia della consapevolezza della discriminazione, sia del turbamento d’animo ad essa conseguente”, per poi essere addirittura disconosciuto del tutto in secondo grado da App. Roma [ord.] 19.10.2012 (in Foro it., 2013, I, 1674, con nota di M. Militello) sia perchè non sarebbe stato ritenuto provato in concreto il pregiudizio, sia perché, a detta della Corte, ad altri strumenti l’art. 28 demanderebbe la funzione dissuasiva e punitiva (sanzione penale e decadenza da specifici benefici), ma non al risarcimento del danno, che sarebbe connotato unicamente da finalità “riparatoria per equivalente” della lesione.
Sulla quantificazione in via equitativa emerge spesso la tendenza, che pare in dissonanza con la funzione dissuasiva, sia a trascurare la valutazione della condotta del soggetto agente che a parametrare la liquidazione sulla valutazione economica dell’occasione perduta dalla vittima: v. Trib. Prato, 10.9.2010 (v. i riferimenti sub n. 16) che, in un caso di lavoratrice discriminata da un ente pubblico all’atto della sottoscrizione di un contratto a termine con il rifiuto all’assunzione determinato dallo stato di gravidanza, ha commisurato la liquidazione all’importo delle retribuzioni che sarebbero state percepite nel caso in cui il rapporto fosse stato attivato negando peraltro la sussistenza di un interesse alla pubblicazione del provvedimento; in caso analogo, ma relativo a fattispecie di contratto a tempo indeterminato presso un datore di lavoro privato, App. Milano, 17.6.2009, (in Rivista critica di diritto del lavoro privato e publico, 2009, 975 ss., con n. di A. Guariso) l’importo è stato calibrato sulla retribuzione di un’annualità come percepita da lavoratrice assunta con la stessa selezione dell’esclusa.
Per una pronuncia di interesse sui criteri di quantificazione, si veda Trib. Varese, sez. Luino, 23-27 aprile 2012 n. 31 (in www.personaedanno.it), relativo ad una fattispecie di aggressione violenta per ragioni razziali, che dopo aver disposto (per altro con corposa “personalizzazione”) il risarcimento del danno biologico, ha condannato gli autori al risaricmento del danno non patrimoniale da discriminazione (più precisamente: per il pregiudizio all’”identità culturale e personale”) ritenendolo meritevole di autonoma liquidazione, e determinandolo in misura pari a quella relativa al danno alla salute; da evidenziare, per ciò che qui interessa, il passaggio nel quale la pronuncia ha dato conto degli elementi presi in considerazione per la determinazione: ”la modalità del fatto, la preordinazione dell’illecito; l’odiosa ostentazione delle finalità razziali; il fatto che l’offesa sia avvenuta in “gruppo”, con modalità aggressive, quindi, in cui la vittima era nella totale signoria degli aguzzini; il tipo di lesioni inferte (al capo), indicative di una intenzione esplicita ed espressa nel senso di cagionare i danni poi effettivamente provocati”.
Per esempi di valorizzazione dell’azione collettiva e di liquidazione del danno non patrimoniale jure proprio all’organismo rappresentativo dell’interesse leso, si veda Trib. Bergamo [ord.] 6.8.2014, n. 791 (in www.unar.it) che ha stabilito la discriminatorietà – sub species di discriminazione diretta ex art. 2, comma 1, lett. a) d. lgs. 216/03 – delle dichiarazioni rese da un noto avvocato nel corso di un’intervista rilasciata in un programma radiofonico, e consistenti nella reiterata affermazione di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e/o lavoratori omossessuali. La pronuncia si segnala per aver espressamente qualificato il danno liquidato all’associazione ricorrente per i diritti lgbt come “sanzione”, per aver affermato l’ammissibilità del risarcimento all’ente anche nei casi in cui non vi siano vittime identificabili, per il richiamo agli indirizzi UE sulla non conformità di liquidazioni simboliche, per l’associazione della misura risarcitoria con l’ordine di pubblicazione della pronuncia ai fini di un risultato “adeguatamente dissuasivo”. La decisione è stata confermata integralmente da App. Brescia, 11.12.2014 (in www.studiodirittielavoro.it), recante, fra l’altro, un interessante approfondimento della nozione di “interesse collettivo” valevole ai fini dell’art. 5, d. lgs. 215/03. Ed ancora, Trib. Pistoia, 8.9.2012 (in Rivista italiana di diritto del lavoro 2013, I, 25, con nota di R. Del Punta), confermata da App. Firenze 11.7.2013, n. 968 (in Rivista giuridica del lavoro, 2014, n. 4, 624 ss. con nota di D. Izzi), che ha liquidato il danno non patrimoniale sia alle singole ricorrenti che all’Ufficio della Consigliera di Parità jure proprio in una causa avente ad oggetto molestie sessuali da parte del datore a danno di una collettività di lavoratrici (non tutte immediatamente indiduabili), oltre a vari illeciti gesionali.
Sulla posizione della Consigliera risaltano i significativi importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale jure proprio, gli approfonditi richiami alla funzione dissuasiva richiesta a livello sovranazionale, e l’efficace connubio fra il rimedio risacitorio e quello ripristinatorio – individuato nell’obbligo per il datore di notifica della pronuncia a tre lavoratrici rimaste fuori dal processo, ma i cui nominativi erano emersi in istruttoria, con l’avvertenza della facoltà di agire per il ristoro dei danni – ma, forse ancor prima la stessa ammissibilità dell’azione collettiva nel caso di atti di molestia sessuale, non ancora definitivamente data per scontata dalla dottrina, soprattutto con riferimento a casi di vittime non individuate(22). Di interesse, in punto di prova del danno alla dignità personale, il passaggio nel quale il Tribunale ha ritenuto che – affermata l’astratta risarcibilità derivante dalla previsione ex lege – gli oneri incombenti sulle attrici dovessero considerarsi limitati all’affermazione ed alla dimostrazione delle molestie sessuali, peraltro rivelatesi nel caso di specie reiterate e commesse nell’ambito di rapporti di lavoro apparentemente precari e quindi in una condizione di speciale vulnerabilità delle persone offese(23).
Sul piano dei criteri equitativi di liquidazione alle due ricorrenti,avvenuta in misura differente, la pronuncia di primo grado è altresì interessante per l’implicita ma evidente considerazione, fra i vari criteri di personalizzazione, del diverso regime di protezione dei vincoli lavorativi, con il riconoscimento di un risarcimento del danno non patrimoniale nettamente superiore alla lavoratrice non in grado di invocare, per essersi volontariamente dimessa, la tutela reintegratoria ex art. 18 St.l.
In conclusione della presente, molto sommaria, casistica, occorre segnalare Cass. 30.12.2014 n. 27481 (in www.personaedanno.it), una delle più recenti decisioni in materia di stipulazione abusiva di contratti a termine nella pa, che ha compiuto affermazioni di principio di fondamentale importanza sui temi sin qui affrontati, dichiarando
espressamente di aver attinto analogicamente ai principi UE in tema di discriminazione per ciò che concerne sia i connotati che la prova del danno non patrimoniale. La pronuncia ha tratto origine dal ricorso promosso da una lavoratrice a termine della Regione Val d’Aosta avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, sia pure confermando l’illegittimità dei contratti stipulati dalla ricorrente, in accoglimento dell’appello dell’amministrazione aveva riformato il capo della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato la Regione al risarcimento del danno corrispondente a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ritenendo che nessuna deduzione/allegazione fosse stata fornita in merito al danno patito. Il giudice di legittimità, con un espresso richiamo al dovere di interpretazione conforme, ha indicato quale nozione di danno da prendere a riferimento per il ristoro previsto dall’art. 36, comma 5, d. lgs. 165/2001 quella di “danno comunitario”, precisando che la liquidazione
deve osservare i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività del diritto UE, e che esso “è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro”. In alcuni passaggi la pronuncia si è soffermata anche sulla questione della prova del danno, e richiamando la nota ordinanza Corte Giust. 12.12.2013, Papalia c. Com. Aosta, C-50/13 (in Rivista giuridica del lavoro, 2014, II, 242 (m), con nota di R. Nunin), ha rammentato che il regime applicabile al caso di specie dev’essere analogo a quello delle fattispecie discriminatorie, concludendo che deve ritenersi sufficiente per il ricorrente provare mediante presunzioni l’illegittima e reiterata stipulazione di contratti a termine recanti non genuine esigenze straordinarie e temporanee, per addossare all’amministrazione convenuta la prova dell’insussistenza dell’abuso, e per far sì il ricorrente sia esonerato, sul fronte risarcitorio, dalla costituzione in mora del datore e dalla prova di un danno effettivamente subito. Va detto che la sentenza, di estrema significatività per l’affermazione del principio, ha finito però per arretrare notevolmente sul piano pratico, nella parte in cui, nel dettare i parametri ai quali la liquidazione del danno dovrebbe essere ancorata, ha indicato, in maniera non certo coerente con le premesse, quale “criterio tendenziale” quello di cui all’art. 8, l. 604/66 e dunque una soglia certamente penalizzante rispetto a quella adottata da altre pronunce precedenti, che si erano basate per esempio, sull’applicazione analogica del sistema indennitario di cui all’art. 32 l. 183/2010 o del criterio ex art. 18 St. l.24.
3. I condizionamenti della struttura del processo.
Non si può infine non accennare al fatto che, non solo la funzione dissuasiva, ma la stessa effettività della tutela, in generale, rischiano di essere radicalmente compromesse da modifiche processuali che, sotto dichiarati intenti di maggiore efficienza e celerità del processo decisionale, finiscono per imbrigliare – quando non talvolta inibire – l’opera di accertamento del giudice.
Al discorso che segue occorre fare una premessa, per rammentare, richiamando quanto già evidenziato in apertura, che l’ordinamento europeo in materia di discriminazioni non impone affatto agli Stati membri di introdurre procedimenti speciali attraverso i quali realizzare l’obiettivo di una tutela effettiva, dissuasiva e proporzionata: la normativa di riferimento si limita infatti ad imporre l’adozione di “procedure adeguate”(25), che prevedano cioè un onere prova agevolato per il ricorrente, con possibilità di ricorso alle presunzioni, che eventualmente consentano alle associazioni portatrici dell’interesse protetto, a seconda del caso, di promuovere azione giudiziale o di esperire intervento adesivo a supporto della vittima, che estendano la platea dei soggetti tutelati a coloro che, pur non direttamente discriminati, abbiano subito provvedimenti ritorsivi per essersi attivati a difesa del principio di pari
opportunità (per esempio, rendendo testimonianza a favore del collega discriminato in una controversia che ha visto il datore di lavoro in veste di convenuto), e tutte le ulteriori utilità che non è qui possibile analizzare in dettaglio.
Il giudizio, quale che sia il vestimento processuale dell’azione, deve tendere alla realizzazione dello scopo, come anche affermato in un passaggio da Corte Giust. 10.7.2008, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. Firma Feryn NV, causa C – 54/07(26),relativamente al divieto di discriminazione per razza ed origine etnica: “L’art. 15 della direttiva 2000/43 impone quindi agli Stati membri l’obbligo di prendere nel loro ordinamento giuridico provvedimenti adeguati, idonei a raggiungere lo scopo della detta direttiva, e di
garantire che tali provvedimenti possano essere effettivamente invocati dinanzi ai giudici nazionali in modo che la tutela giurisdizionale sia effettiva ed efficace”.
Da ciò deriva non solo che non necessariamente debbano essere coniati procedimenti speciali se l’ordinamento già prevede delle forme idonee, ma anche che – per contro – laddove fra gli strumenti procedurali che l’ordinamento contempla non ve ne sia nemmeno uno adeguato, in tutto o anche solo in parte, nei termini imposti dalle direttive UE, si debba concludere per la sussistenza di un difetto di conformità rispetto al livello sovranazionale.
E la seconda ipotesi mi pare si sia decisamente avverata da quando la riforma del mercato del lavoro attuata con la l. 92/2012 ha imposto, ogni qualvolta occorra impugnare un licenziamento invocando le conseguenze ex art. 18 St.l., e dunque senza dubbio quando si intenda far accertare la discriminatorietà del recesso datoriale, di introdurre la domanda con il rito speciale di cui all’art. 1, comma 47 e ss., della legge citata.
Rito ormai diffusamente ritenuto necessario e non alternativo a quello ordinario ex art. 414 c.p.c., e nel quale, per giunta, non è ammessa la proposizione di domande diverse da quelle fondate sui medesimi fatti costitutivi del licenziamento.
Chi osserva da pratico le fattispecie discriminatorie sa bene che la vicenda discriminatoria non dà quasi mai luogo ad una condotta “istantanea”, che nasce e si esaurisce con il gesto del licenziamento, ma è al contrario quasi sempre una “storia”, complessa, che viene da lontano, di multiforme violazione della dignità del soggetto portatore del fattore protetto.
Attngendo, tanto per fare un esempio, alla fattispecie recentemente affrontata da Trib. Pistoia, 8.9.2012, in Rivista italiana di diritto del lavoro 2013, I, 25, e da App. Firenze 11.7.2013, n. 968 su un caso di molestie sessuali “collettive” disciplinato ratione temporis dalle regole processuali antecedenti la riforma Fornero, la giovane occupata,
dopo un periodo di totale irregolarità, con contratto atipico, ma con iniziali prospettazioni di carriera, che poi viene licenziata per ragioni disciplinari pretestuose a seguito del rifiuto di sottostare alle avances del datore, alla fine di un percorso lavorativo funestato da attenzioni sessuali indesiderate, da retrocessioni ritorsive, dall’imposizione di lavoro extraorario non retribuito, dall’adibizione a lavori faticosi inconferenti rispetto ai compiti pattuiti, dal tentativo di induzione alle dimissioni e da altri illeciti gestionali volti a fiaccarne la volontà, deve essere messa in
grado di rappresentare la propria vicenda nella sua interezza al giudice e di domandare ogni necessario accertamento, al fine di ottenere una tutela risarcitoria e ripristinatoria piena ed effettiva, senza dover frammentare la domanda e gravarsi dell’onere (non solo economico, ma anche emotivo) di introdurre diversi giudizi, uno per il licenziamento, e (almeno) un altro per tutto il resto.
E se, com’è avvenuto nello specifico caso, quel datore di lavoro si è rivelato un molestatore “seriale”, avendo tenuto il medesimo comportamento nei confronti di più dipendenti, ciascuna con la propria personale storia di mortificazioni lavorative, magari esitata in maniera diversa dal licenziamento, per esempio, per dimissioni, laddove ricorrano i presupposti, dev’essere consentita la riunione dei procedimenti avviati con i singoli ricorsi individuali, per un pieno apprezzamento da parte del giudice del reale grado di disvalore della condotta.
Ed ancora, se fra le lavoratrici molestate ve ne sono alcune certamente esistenti, ma non immediatamente individuabili, o che non hanno avuto la forza per azionare i propri diritti, deve potersi dispiegare l’azione pubblica e autonoma della Consigliera (e il discorso è analogo, nel caso di licenziamento discriminatorio riferibile a fattori diversi dal genere, per le associazioni legittimate), con possibilità di riunione o trattazione congiunta con il primo giudizio, non solo ai fini del piano di rimozione (che per la verità, nel caso specifico, potrebbe anche non
essere soluzione percorribile), ma anche del risarcimento del danno subito dall’Ufficio jure proprio, a fronte di condotte che oltre ad incidere pesantemente sulla sfera soggettiva di ciascuna vittima, sono, come quella in discorso, idonee ad inficiare la capacità rappresentativa dell’Ente in relazione all’interesse protetto e dunque ad indebolirne l’efficacia di azione a scapito dell’intera collettività.
Ecco la ragione per cui con l’assolvimento dei bisogni sin qui indicati, l’imposizione del rito Fornero per l’impugnativa di licenziamento non mi pare per niente compatibile, per la pressoché totale preclusione delle ipotesi ora esemplificate (27): nei casi più articolati di licenziamento discriminatorio, che rappresentano una parte niente affatto esigua, il rischio è dunque quello di non poter sottoporre alla cognizione del giudice che uno spaccato parziale, frammentato, non correttamente messo a fuoco, e dunque che non ci siano sin dalla proposizione della domanda le condizioni adatte a giungere ad una tutela efficace, proporzionata e dissuasiva.
Non rimane, rebus sic stantibus, che tentare di affermare(28), sotto la guida del principio di interpretazione conforme e dall’affermazione del primato del diritto europeo nella specifica materia, la perdurante esperibilità per il licenziamento discriminatorio – ad onta della formulazione letterale dell’art. 1, comma 47, l. 92/2012 – dei preesistenti rimedi processuali speciali disegnati in attuazione delle direttive europee, segnatamente quelli da ultimo convogliati attraverso l’art. 28 d. lgs. 150/2011 verso il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e già elencati sub § 1. Ciò, non potendosi ritenere compatibile con l’ordinamento UE una norma di diritto interno che, su una fattispecie cruciale come quella del licenziamento, di fatto provoca una sterilizzazione degli strumenti rimediali predisposti dal legislatore in attuazione delle direttive comunitarie sui divieti di discriminazione. Il percorso è arduo, per l’incombenza dello spettro della inammissibilità e così della decadenza prevista dall’art. 6, comma 2, l. 604/1966 (così come modificato dall’art. 32 l. 183/2010 e dall’art. 1, comma 38, l. 92/2012), e del tutto desolante essendo, allo stato, il silenzio della giurisprudenza, se si fa eccezione – per quanto consta – per un’isolata
pronuncia di merito(29).
1 V. invece, per alcune aperture dottrinali ad ulteriori funzioni del danno, G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano, Giuffré, 1983, 297 ss.; A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, Giuffrè, Milano, 2003, 173 ss.; A. Donati, Danno non patrimoniale e solidarietà, Cedam, Padova, 2004, 82; C. Salvi, La responsabilità civile, Giuffré, Milano, 37 ss.; C.
Scognamiglio, Danno morale e funzione deterrente della responsabilità civile», in Resp. civ. prev. 2007, 2485 ss.; E. Navarretta, Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali, in Responsabilità civile, 2008, 505; P.G. Monateri – D. Gianti – L. Siliquini Cinelli, Danno e risarcimento, in Trattato sulla responsabilità civile (diretto da P.G. Monateri), Giappichelli, Torino, 2013.
2 V., esemplificativamente, Cass. 11.8.1998, n. 7905, Cass. 19.3.1999, n. 2561, Cass. 4.6.2003, n. 8904; Cass. 18.11.2003, n. 16792; Cass. 28.5.2004, n. 10361.
3 Per una approfondita riflessione sulla tradizionale e paradossale difficoltà del diritto del lavoro nell’affrontare la tematica del risarcimento del danno alla persona del lavoratore e sui condizionamenti che ne sono derivati al diritto antidiscriminatorio “di prima generazione” v. R. Del Punta, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Atti del Convegno Aidlass 31.3- 1.4.2006, Giuffrè, 2007.
4 F. Malzani, Mobbing e tutela penale. Alla ricerca di convergenze parallele; in Rivista critica di diritto del lavoro, 2009, 625 ss., in particolare sub nota 11, nonché A. Guariso, Ancora sulle conseguenze del comportamento discriminatorio: nodi irrisolti anche dopo il D. Lgs. 5/10, in Rivista critica di diritto del lavoro privato e pubblico, 2009, p. 976
5 Sulla non conformità ai prinicipi comunitari in tema di discriminazioni di genere del massimale risarcitorio, v. anche Corte Giust. 2.8.1993, C – 271/91, Marshall c. Southampton South West, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1994, II, 3.
6 In questo senso non pare condivisibile la ricostruzione di A. Guariso, I provvedimenti del giudice, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano, 2007, p. 603, secondo il quale l’introduzione di una tutela risarcitoria con funzione dissuasiva rappresenterebbe per gli Stati membri una mera facoltà e non un vincolo: il risarcimento è certamente solo uno dei possibili mezzi di tutela, ma una volta designato e prescelto dallo Stato membro come specifico strumento rimediale in attuazione della direttiva, non v’è dubbio che debba assolvere le funzioni richieste da quest’ultima. In questo senso parrebbe anche Corte Giust., 22-04-1997, C -180/95, Draehmpaehl c. Urania Immobilienservice ohg, in Il lavoro nella giurisprudenza, 1997, p. 639, con nota di D. Izzi.
7 In generale, sul dovere di interpretazione conforme, v. le sentenze Corte Giust. 10.4.1984, Von Colson e Kamann, C – 14/83, punti 26 e 28; 13.11.1990, Marleasing, C-106/89, punto 8; 10.3.2005, Nikoloudi, C-196/02, punto 73, e 28.1.2010, Uniplex (UK), C-406/08, punti 45 e 46.
8 Per precedenti sul piano normativo, v. l’art. 2, comma 1, l. 117/88 con il riconoscimento dei danni anche non patrimoniali cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie e della responsabilità civile dei magistrati, l’art. 2, comma 1, l. 89/2001 sull’equa riparazione in caso di violazione del principio della ragionevole durata del processo, con la correlata modifica dell’art. 373 c.p.c., l’art. 29, comma 9, l. 675/96 (poi art. 15, comma 2, d. lgs. 196/2003) sulla lesione alla privacy derivante da modalità illecite di trattamento dei dati personali.
9 V., rispettivamente, art. 34, comma 33, lett. b), ed art. 34, comma 34, lett. b), d. lgs. 150/2011.
10 V. A. Guariso, I provvedimenti del giudice, cit., p. 603, nonché, ivi, L. Curcio, Azioni in giudizio ed onere della prova, p. 542.
11 A meno che non si voglia leggere implicitamente la sussistenza dell’obbligo dalle disposizioni che impongono, anche con riferimento alle discriminazioni indirette, la necessità di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive, ma il percorso pare francamente arduo.
12 Così F. Amato, Azione individuale ed azione collettiva, in M. Barbera (a cura di), La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari opportunità, in Nuove leggi civili commentate, 2003, p. 760. Per alcune considerazioni sulla nozione di azione collettiva in un’ipotesi non di genere v., recentemente, S. Borelli, Il diritto antidiscriminatorio nella vicenda Fiat/Fabbrica Italia Pomigliano (Fip) – Fiom, in Rivista critica di diritto del lavoro
privato e pubblico, 2012, 369 ss. , criticando la nota ordinanza di Trib. Roma, III sez. lavoro, 21.6.2012 sul caso Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A./Fiom CGIL Nazionale.
13 Per osservazioni sul tema, v. L. Curcio, Azioni in giudizio ed onere della prova, cit., p. 544.
14 Sulla funzione dissuasiva del danno ex art. 37, comma 3, d. lgs. 198/06 O. La Tegola, Parità e non discriminazione per ragioni di genere, in F. Carinci – A. Pizzoferrato (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione Europea, Utet, Torino, 2010, 460 ss.
15 V., in origine, l’art. 4, comma 6, d. lgs. 215/2003, e l’art. 4, comma 7, d. lgs. 216/2003, ed ora l’art. 28, comma 7, d. lgs. 150/2011.
16 Per alcune considerazioni sulle peculiari funzioni della pubblicazione, sia consentito rinviare a L. Amoriello, La discriminazione di genere nella fase di accesso al lavoro alle dipendenze della pa, nota a Trib. Prato, 10.9.2010, in Rivista critica di diritto del lavoro, 2010, 1063.
17 Per una generale trattazione sul tema, v. L. A. Scarano, La quantificazione del danno non patrimoniale, Giappichelli, Torino, 2013.
18 Nello stesso senso v. A. Guariso, Il diritto antidiscriminatorio tra solennità dei principi e modestia dei rimedi, nota a Trib. Varese 2.7.2008, in Rivista critica di diritto del lavoro, 2008, 947 ss. Sulla necessità di non demandare unicamente al giudice l’individuazione di rimedi sufficientemente dissuasivi v. dello stesso Autore, Ancora sulle conseguenze del comportamento discriminatorio: nodi irrisolti anche dopo il D. Lgs. 5/10, cit., 975 ss.
19 Sul punto paiono condivisibili le conclusioni di P.G. Monateri – D. Gianti – L. Siliquini Cinelli, Danno e risarcimento, cit., 146: “[…] vi è una funzione preventiva, dissuasiva,deterrente e punitiva, e come tale sociale, della r.c., dalla quale in nessun caso è consentito astrarre. Per muoversi coerentemente in questa direzione è necessario riformulare un coerente statuto della r.c. Capace di coordinare in modo efficiente l’ingiustizia del danno, i
criteri di imputazione e le diverse modalità del danno risarcibile”.
20 Già citata sub n. 18, cui si rinvia per i riferimenti.
21 V. anche sub n. 12.
22 V. L. Lazzeroni, Molestie e molestie sessuali: nozioni, regole, confini, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, cit., 404.
23 Di rilievo, in relazione alle considerazioni sull’onere della prova contenute sub § 1 del presente scritto, la considerazione secondo la quale: “[…] Le condotte de quibus infatti, come sopra descritte, realizzano condizioni di fatto obiettivamente idonee a determinare nelle destinatarie delle condotte medesime, se non necessariamente l’insorgenza di una condizione qualificabile come malattia, comunque la causazione di una sofferenza la cui esistenza nell’an è immediatamente apprezzabile in dipendenza della natura dei beni lesi e delle caratteristiche della violazione (secondo una regola di giudizio non diversa da quella di cui si fa abitualmente uso per legare una sofferenza personale ad un lutto)”.
24 Per un riferimento all’indennità ex art. 32 l. 183/2010 v., anche più recentemente, Cass. 12.1.2015, n. 262.
25 V., ad esempio, i considerando nn. 28 e 29 dir. 2006/54 sull’attuazione del principio di parità di genere.
26 In Rivista giuridica del lavoro, 2008, II, 788, con nota di D. Izzi.
27 Si segnala Trib. Pisa [ord.], sez. lavoro, 9.9.2014, inedita per quanto consta, che ha ammesso l’intervento adesivo della Consigliera in un procedimento introdotto da una lavoratrice con rito Fornero, ma al contempo escludendo l’accessibilità per la parte pubblica dell’azione ex l. 92/2012 come sostituto processuale della lavoratrice o del lavoratore interessati o con modalità che comportino l’estensione dell’oggetto del decidere.
28 Per alcune ricostruzioni v. A. Guariso, Legge Fornero n. 92 del 2012: le novità processuali (in www.studiodirittelavoro.it), nonché recentemente, E. Tarquini, La discriminazione sul lavoro e la tutela giudiziale, Giuffré, 2015, 82 ss.
29 V. Trib. Pistoia (ord.), 13 ottobre 2013, inedita, nella quale, nell’accogliere il ricorso ex
art. 700 c.p.c. di una lavoratrice licenziata in stato di gravidanza per la reintegrazione nel posto di lavoro, il Tribunale ha ritenuto possibile l’introduzione della successiva fase di merito attraverso il procedimento speciale ex art. 36 d. lgs. 198/06, anziché con il rito Fornero: “Rappresenta dato notorio che la tutela giudiziaria contro le discriminazioni di genere è molto più ampia e vasta ai sensi dell’art. 18, nuovo testo, l. 300/70. Anzi, peculiari
procedure (di cui agli artt. 36 ss. codice p.o.) posseggono una originale struttura che nemmeno esclude la fase di urgenza […]. Proprio in ragione dei profili discriminatori in precedenza trattati, la distinzione e l’autonomia processuale fra domande e riti si mostra del tutto evidente”.
Lisa Amoriello
Università di Pisa
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT – 264/2015