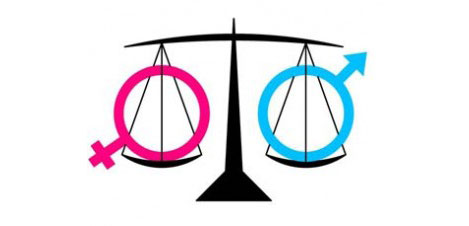ll rispetto delle quote percentuali delle donne come limite inderogabile alla scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi ,Discriminazione di genere, Tribunale di Taranto, Ordinanza del 5 dicembre 2013
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Ordinanza ex L. 28 giugno 2012 n° 92, art. 1, co. 47-48-49
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, nel procedimento promosso da:
A. A
rappr. e dif. dagli avv. Arnese e Di Rito
– Ricorrente –
contro
B TV srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappr. e dif. dall’avv. Bernardi
– Convenuta –
- letti gli atti ed i documenti di causa;
- viste le deduzioni delle parti e sciolta la riserva formulata all’udienza del 28-11-2013;
O S S E R V A
Con ricorso depositato in data 09 settembre 2013 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l’inefficacia e/o l’illegittimità del licenziamento collettivo intimatole con comunicazione del 06/07-08-13 e, per l’effetto, condannare la resistente a reintegrarla nel posto di lavoro, con tutte le ulteriori conseguenze previste dall’art. 18, L. n° 300/70, sì come modificato dalla L. n° 92/12.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto la violazione delle procedure e dei presupposti stabiliti dalla l. 223/91 e in particolare la violazione dell’art.5 comma 2 della medesima legge atteso che è stata licenziata una percentuale di manodopera femminile superiore a quella occupata.
La B Tv srl, ritualmente costituitasi, ha chiesto rigettarsi integralmente il ricorso.
Istruita documentalmente la causa, all’udienza del 28-11-2013 i procuratori delle parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni già formulate e alle note autorizzate depositate. Quindi questo Giudice ha riservato la decisione.
*********************************
Il primo e più importante motivo di censura alla procedura di licenziamento collettivo formulato dalla ricorrente è relativo alla violazione dell’art.5 comma 2 l.223/91, che prevede che “L’impresa non puo’ altresi licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione”.
Nel caso di specie si è proceduto al licenziamento di n. 3 donne e n.1 uomo, mentre erano impiegati n.5 donne e n.3 uomini, tutti pacificamente inquadrati come telegiornalisti. Pertanto la percentuale di manodopera femminile inquadrata come telegiornalista era del 62,5 %, mentre si è proceduto al licenziamento di una percentuale di donne pari al 75%.
Ritiene la società convenuta che quello di cui al comma 2 secondo capoverso sia solo uno dei diversi criteri di scelta di cui all’art.5, valutabile al pari degli altri, ma assolutamente non avente alcuna portata imperativa e sprovvisto di sanzione in caso di mancato rispetto. Al massimo lo stesso può avere rilevanza come indice della sussistenza di un licenziamento discriminatorio, facendo scaturire la violazione della percentuale de quo una presunzione di discriminatorietà del licenziamento stesso, potendo, tuttavia, essere superata dalla prova contraria della corretta applicazione dei criteri di scelta di cui al comma 1 dell’art.5.
Faceva, peraltro, rilevare la convenuta che una diversa interpretazione della norma stessa concreterebbe una violazione degli artt.3 e 37 Cost atteso che ciò comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza e una discriminazione fondata sul sesso a svantaggio degli uomini, in violazione peraltro anche del diritto comunitario ed in particolare della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.
Per contro faceva rilevare la ricorrente che la predetta norma non è affatto discriminatoria nei confronti degli uomini atteso che la stessa non impone in alcun modo di licenziare manodopera maschile o di accordare una tutela preferenziale alle donne, quanto piuttosto impone di salvaguardare l’equilibrio della quota percentuale preesistente tra lavoratori e lavoratrici occupati.
Orbene opina questo Tribunale che la decisione possa essere assunta allo stato degli atti e che la domanda attorea – ovviamente nei limiti della sommarietà della cognizione che caratterizza la presente fase processuale – sia accoglibile, sembrando fondate le deduzioni attoree.
L’art.5 comma 1 l. 223/91 prevede che “L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;
- a) carichi di famiglia;
- b) anzianita’;
- c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.”
Successivamente il legislatore al comma 2 individua due limiti alla predetta facoltà di scelta, ossia il rispetto delle cd quote per quanto concerne le categorie tradizionalmente deboli, ossia disabili e donne.
In altre parole il legislatore ha voluto fissare due paletti alla facoltà di scelta da parte del datore di lavoro dei dipendenti da licenziare nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ossia il rispetto di determinate percentuali per quanto concerne la fuoriuscita dal lavoro di disabili e donne. Solo una volta rispettati questi limiti è poi possibile procedere ad applicare gli altri criteri di scelta individuati dalla contrattazione collettiva o dalla legge (carichi di famiglia, anzianità lavorativa ed esigenze tecnico-produttive), questi sì, come detto esplicitamente dallo stesso legislatore, da valutarsi in concorso tra loro.
Tale interpretazione della norma non pare possa revocarsi in dubbio.
In particolare già solo guardando al tenore letterale della stessa, si evince che essa è chiara nel dire che l’impresa NON PUO’ licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore a quella occupata, ponendosi come norma imperativa, che impone inequivocabilmente un preciso divieto all’imprenditore che voglia ricorrere alla procedura di cui alla l.223/91.
Peraltro si deve intendere quell’ “altresì” (“l’impresa non può altresì licenziare…”) come riferito al primo limite alla facoltà di scelta da parte del datore di lavoro, ossia quello relativo ai disabili, nel senso che, oltre a quel limite, v’è ne uno ulteriore, relativo alla manodopera femminile, e non certo al comma 1, lì dove sono esaminati i criteri di scelta, come se si volesse solo aggiungere a quelli già individuati un ulteriore criterio di scelta.
In altri termini la norma è estremamente chiara nel prevedere come rigido ed inderogabile il rispetto del limite percentuale di manodopera femminile impiegata nelle mansioni prese in considerazione per la riduzione di personale, sicchè lo stesso deve configurarsi più come un limite invalicabile per l’imprenditore che come un mero criterio di scelta, tanto da essere volutamente collocato in diverso comma.
In particolare il riferimento alla percentuale di manodopera femminile occupata con le mansioni considerate nella procedura di mobilità rappresenta un criterio vincolante, atto ad individuare un tetto massimo di lavoratrici licenziabili, non derogabile dagli accordi collettivi, come invece i criteri di scelta di cui al comma 1.
Né condivide questo Giudice l’assunto di parte convenuta in merito al fatto che tale norma abbia l’unica finalità di agevolare la prova del licenziamento discriminatorio per la lavoratrice, costituendo una mera presunzione relativa superabile mediante prova contraria.
Trattasi, infatti, al massimo di presunzione assoluta, non suscettibile di prova contraria, come può accadere nel caso del licenziamento della lavoratrice madre entro il primo anno di vita del bambino o della lavoratrice entro l’anno dal matrimonio.
Ritiene la convenuta che la norma, al di la del significato letterale, debba essere interpretata in maniera conforme alla normativa comunitaria ed in particolare alle Direttive in materia di pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego.
Tanto porterebbe a ritenere che se il diritto comunitario (in particolare l’art.19 Dirett 2006/54/CE) prevede che sia il convenuto – datore di lavoro ad avere l’onere di provare che non vi è stata discriminazione, una interpretazione conforme allo stesso dell’art.5 comma 2 porterebbe a ritenere comunque superabile la presunzione di discriminatorietà del licenziamento collettivo mediante la prova del rigoroso rispetto dei criteri legali di cui all’art. 5 comma 1.
In realtà va detto che il diritto comunitario, proprio al fine di evitare disparità di trattamento ed al fine di agevolare la prova della discriminazione, per sua natura difficoltosa, se non diabolica, ha previsto (e la normativa italiana si è a ciò adeguata con l’art.40 del Codice delle pari opportunità) una agevolazione probatoria per chi in base ad elementi di fatto, desunti anche da dati statistici, si ritenga vittima di una condotta discriminatoria, ossia l’inversione dell’onere della prova. Ha previsto, pertanto, che sia, contrariamente a quanto accadrebbe in base alle regole generali sul riparto della prova, il datore di lavoro a dover fornire la prova della insussistenza della discriminazione, con ciò rafforzando la tutela delle categorie più deboli.
Ovviamente ciò non comporta affatto che il legislatore nazionale non possa ulteriormente rafforzare la tutela dei soggetti deboli, quali appunto le donne, prevedendo non solo presunzioni semplici, ma addirittura presunzioni assolute.
Pertanto se normalmente, per esempio in caso di licenziamento individuale, la donna che voglia provare la natura discriminatoria dello stesso dovrà allegare degli elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, tanto da essere idonei a fondare la presunzione della sussistenza di un licenziamento discriminatorio, e spetterà poi al datore di lavoro provare il contrario, nel caso di un licenziamento collettivo in cui sia violata la previsione dell’art.5 comma 2 ultimo capoverso è lo stesso legislatore a prevedere direttamente ex lege che tale condotta è discriminatoria, senza possibilità di fornire prova contraria. In altre parole se vi è un divieto espresso di licenziare una percentuale di donne superiore a quella impiegata e lo stesso viene violato, per ciò solo quel licenziamento ha natura discriminatoria.
Né la Corte di Giustizia ha mai censurato la disciplina italiana nei casi analoghi di licenziamento della lavoratrice madre o della lavoratrice che abbia contratto matrimonio, in cui pure la natura discriminatoria del licenziamento è in re ipsa, salvo, in quanto espressamente previsto dalla legge, la prova della giusta causa o della cessazione dell’attività.
Resta allora, così interpretata la norma, da valutare se la stessa sia o meno costituzionale, come posto in dubbio dalla convenuta.
Ritiene questo Giudice che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 comma 2 l. 223/91 con riferimento agli artt. 3 e 37 Cost non sia fondata.
Erra la convenuta, infatti, nel ritenere che la norma in questione costituisca una violazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne a tutto vantaggio delle donne.
Questo sarebbe indubitabilmente vero allorchè la stessa prevedesse che in caso di licenziamento collettivo non possano licenziarsi più donne che uomini, a prescindere dalla percentuale delle donne impiegate nell’azienda. In questo caso avremmo, infatti, una evidente disparità di trattamento tra sessi. Pertanto se una azienda impiega molte più donne che uomini potrà ovviamente licenziare molte più donne che uomini e sarebbe incostituzionale se, invece, vi fosse una norma che prevedesse l’impossibilità di licenziare un numero di donne maggiore del numero di uomini.
Tuttavia, non è questo che la norma censura, bensì il mancato rispetto della proporzione già esistente tra uomini e donne.
In altri termini il legislatore ritiene che anche in fase di licenziamento il rapporto numerico tra uomini e donne all’interno di una azienda debba rimanere invariato, sicchè non è in alcun modo ravvisabile alcuna tutela preferenziale per le donne a svantaggio degli uomini.
Pertanto non si tratta affatto di preferire le donne agli uomini, privilegiando questi ultimi in caso di licenziamento, ma solo di evitare che ad essere licenziate siano solo o prevalentemente donne, anche se le stesse sono per ipotesi numericamente inferiori agli uomini all’interno dell’azienda.
Ed anzi tale norma è proprio espressione della assoluta parità esistente tra uomini e donne sul lavoro di cui all’art.37 Cost. (la donna lavoratrice ha gli stessi diritti che spettano al lavoratore), sicchè devono essere licenziati tante donne e tanti uomini nella stessa percentuale in cui sono impiegati.
Peraltro l’art.23 della Carta fondamentale dell’Unione Europea prevede che “la parità tra uomo e donna deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, lavoro e retribuzione, ma non osta al mantenimento o alla introduzione di misure che prevedano specifici vantaggi a favore del sesso sottorappresentato”.
Pertanto ben è possibile il mantenimento nel nostro ordinamento di una norma che tuteli le donne da licenziamenti discriminatori, soprattutto ove la stessa, mirando ad evitare la discriminazione nei confronti delle donne, non giunga all’eccesso opposto di favorire le stesse a discapito degli uomini in violazione del principio di parità fra sessi, costituzionalmente previsto prima ancora che imposto dal diritto comunitario.
A tale opzione ermeneutica è di conforto quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 46 del 1993, laddove ha affrontato il problema della compatibilità tra la tutela della lavoratrice madre o nubenda con i criteri di scelta di cui alla l.223/91.
In particolare la Corte Costituzionale in quella occasione ha affermato che “In quest’ultima ipotesi la scelta del legislatore del 1963 di coordinare la legge n. 7, oltre che con la politica di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti, anche con la politica di favore per il matrimonio e di agevolazione della formazione della famiglia legittima, non può essere commisurata ai criteri di selezione dei lavoratori da licenziare, specificati nell’art. 5 della legge n. 223 del 1991, e censurata, in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, perchè al posto della lavoratrice protetta dall’art. 1 della legge potrà essere licenziata una lavoratrice sposata da più di un anno o un lavoratore con maggiore anzianità aziendale e/o con carichi di famiglia più pesanti. Confronti di questo tipo possono essere fatti soltanto tra due lavoratori entrambi soggetti al potere di licenziamento dell’imprenditore, mentre la lavoratrice in questione a tale potere è sottratta fino a quando non compirà un anno di matrimonio. Nel dettare i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità o da licenziare per riduzione del personale ai sensi dell’art.24, l’art. 5 della legge n. 223 si riferisce ai lavoratori per i quali non sussista, in forza di altre leggi, un divieto di licenziamento. Per quelli tutelati da cause attributive del diritto alla conservazione del posto non si può dire propriamente – come si legge nell’ordinanza di rimessione – che altri lavoratori, eventualmente dotati, ai sensi del citato art. 5, di maggiori titoli a rimanere in azienda, verranno a trovarsi licenziati in loro vece.”
Pertanto appare evidente come estensivamente vadano applicati anche al caso di specie gli stessi principi e come, dunque, non possa dirsi fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla convenuta.
In particolare i criteri di scelta di cui al comma 1 dell’art.5 possono applicarsi solo in via subordinata al rispetto di norme (tra cui anche il comma 2 del medesimo articolo) che riguardino divieti di licenziamento, sicchè non v’è violazione di alcuna norma costituzionale allorchè venga licenziato un lavoratore uomo, pur avente maggiori titoli a rimanere in azienda, se ci sono donne tutelate da cause attributive del diritto alla conservazione del posto, siano esse legate alla qualità di lavoratrice madre o nubenda o al rispetto della percentuale di manodopera femminile impiegata.
Chiarito, pertanto, che la norma prevede un limite alla facoltà di scelta dei lavoratori da licenziare da parte dell’imprenditore, ma che il predetto limite è del tutto conforme alla Costituzione nonché al diritto comunitario, giova esaminare un altro aspetto problematico della vicenda,ossia quale è la sanzione apprestata dall’ordinamento alla violazione dell’art.5 comma 2 l.223/91.
Orbene opina questo Tribunale, in totale assenza, per quanto consta, di precedenti giurisprudenziali tanto di legittimità quanto di merito sul punto, che l’unica sanzione comminabile sia quella della nullità del licenziamento.
In effetti il dato testuale sembrerebbe deporre a favore della tesi della convenuta nel senso che si tratterebbe di una norma sprovvista di sanzione in caso di sua violazione atteso che il comma 3 dell’art.5 l.223/91, come modificato dall’art.1 comma 46 l. 92/12, prevede espressamente che “In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18”. Il suddetto articolo cui si rinvia dispone che il giudice annulli il licenziamento stesso, con reintegra del lavoratore e pagamento di una indennità risarcitoria.
Pertanto la conseguenza della violazione dei criteri di scelta di cui al comma 1 è l’annullabilità del licenziamento. Nulla si dice con riferimento alla violazione del limite di cui al comma 2, invece.
Ebbene ritiene questo Giudice che nel caso di specie non si tratti di ipotesi di annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, bensì di licenziamento discriminatorio affetto pertanto da radicale nullità.
Il licenziamento in violazione dell’art.5 comma 2 l.223/91 è, dunque, radicalmente nullo in quanto discriminatorio essendo una possibile ipotesi, tipizzata in questo caso dalla legge, di licenziamento discriminatorio.
In particolare il divieto di licenziare manodopera femminile in eccesso relativo rispetto a quella maschile è una estrinsecazione del divieto generale di discriminazione previsto dal nostro ordinamento (pur molto particolare riguardando la discriminazione nei confronti delle sole donne e non ammettendo cause di giustificazione).
Pertanto dovrà applicarsi quanto previsto dal nostro ordinamento per i licenziamenti discriminatori individuali.
In particolare l’art.3 l.108/90 (rubricato “licenziamento discriminatorio”) ha previsto che “Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e’ nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.”
Ed oggi vi è altresì la espressa previsione del comma 1 dell’art.18 L. 300/70 che disciplina proprio le conseguenze del licenziamento discriminatorio affermando che “ Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita’ del licenziamento perche’ discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, [….]ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. […] Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi’ il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita’, stabilendo a tal fine un’indennita’ commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra’ essere inferiore a cinque mensilita’ della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e’ condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Pertanto il licenziamento in violazione dell’art.5 comma 2 ultimo capoverso l.223/91 sarà nullo con conseguente reintegrazione della lavoratrice il cui licenziamento abbia prodotto il mancato rispetto del tetto massimo di lavoratrici licenziabili.
E a tal proposito giova precisare che nel caso di specie non v’è dubbio che il licenziamento nullo sia proprio quello della ricorrente e non quello di altra lavoratrice parimenti licenziata all’esito della procedura di licenziamento collettivo, atteso che, in considerazione di quelli che sono i criteri di scelta di cui al comma 1 dell’art.5 e dei punteggi conseguentemente attribuiti, la stessa ricorrente è stata la prima dei licenziati, sicchè è logico che sia essa la lavoratrice da reintegrare.
Conseguentemente nel caso di specie il licenziamento della lavoratrice in violazione della percentuale di manodopera femminile sarà nullo, con conseguente reintegra della stessa e pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto (che dalla documentazione prodotta ammonta ad € 1900,00 lorde mensili) dal licenziamento alla effettiva reintegra.
Peraltro nulla è emerso nel corso del giudizio circa l’eventuale aliunde perceptum, sicchè deve ritenersi che alcunché vada a tale titolo detratto.
Restano, pertanto, assorbite tutte le ulteriori censure mosse dalla ricorrente.
In definitiva il ricorso merita accoglimento.
Quanto alle spese la assoluta novità della questione e la complessità della stessa legittimano la compensazione di metà delle spese di lite, restando la restante parte, liquidata come da infrascritto dispositivo, a carico della soccombente convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l’effetto dichiarata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 06-08-2013, condanna la convenuta B. TV srl alla reintegrazione della stessa nel proprio posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la convenuta altresì alla rifusione della metà delle spese processuali, liquidate in complessivi €.1.100,oo ex D.M. n° 140/12, oltre IVA e CPA;
- spese compensate per la restante parte;
- manda alla Cancelleria per le notifiche di rito.
Taranto, 05-12-13
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)